I custodi viventi del fatto a mano (e bene)
di Aldo Bonomi Microcosmi IlSole24Ore
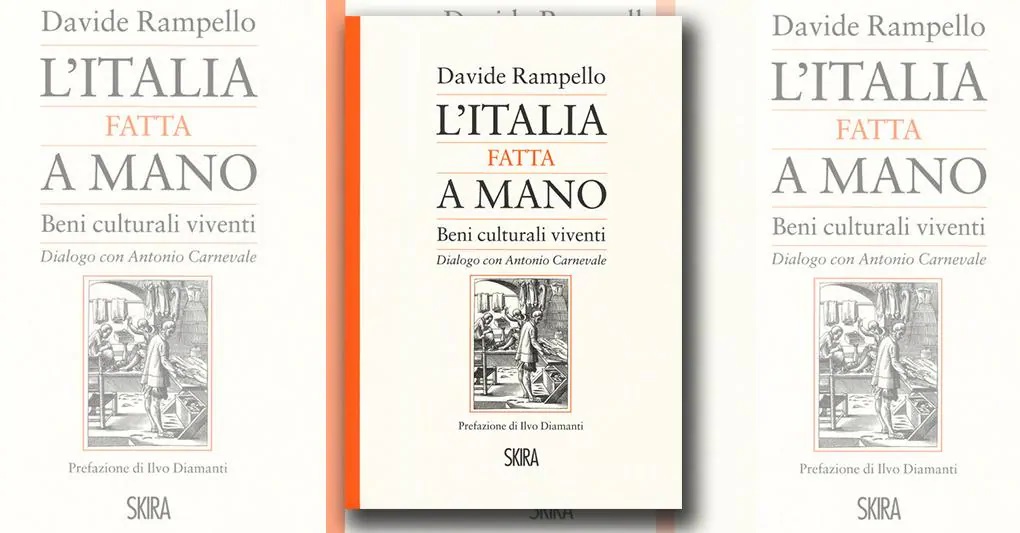
Titolare un libro L’Italia fatta a mano come ha fatto Davide Rampello (Skira, 184 pagine, 24,50 euro) sa di nostalgia. Di sguardo rivolto all’indietro verso un’Italia che non è più. Impressione ingannevole, fugata e messa nella contemporaneità dal sottotitolo: I beni culturali viventi. Questi beni sono anche la vita nuda delle persone, i loro bisogni, i loro desideri di plasmare il mondo non più guidati solo dal mito del progresso espansivo, ma anche dalla necessità di trovare nuovi-antichi riferimenti che incorporano il concetto del limite. I beni culturali viventi custodiscono nel profondo dell’antropologia i saperi contadini, artigiani e commerciali, le infinite sfaccettature e suggestioni del “patrimonio genetico culturale”, incardinato nei milieu locali, per riprodurli nella contemporaneità.
Rampello coltiva l’ambizione, confortata dalle lunghe derive della storia, di indicare una prospettiva che tenga assieme tradizione e innovazione all’insegna di un nuovo umanesimo operoso. Per questo si parte dalla dimensione del piccolo è “prezioso”, parente dell’”intimo” di Becattini, intendendo con ciò alludere a quell’enorme bacino di saperi contestuali, localizzati, addirittura personificati nella civiltà dei “maestri”, che ha sempre fatto da base sociale e culturale al nostro modello di capitalismo di territorio dalle botteghe artigiane ai distretti, dai poderi alle filiere agroalimentari. Il racconto è tutt’altro che passatista, punta semmai a ricordarci come nella discontinuità del tempo dell’innovazione disruptive, sia importante non perdere la nostra ombra: quella di chi sa fare della tradizione una ricerca di continuità orientata all’innovazione. Quell’ombra si riflette nell’anima di quel “popolo dei produttori” oggi privo di narrazione, privo di un “immaginario sociale” per cui, come dice Richard Sennet dell’Uomo artigiano «È mal costruita l’istituzione sociale che ignora l’aspirazione dei suoi membri ad una vita lavorativa che abbia un senso».
Anni fa con Rampello presidente della Triennale mettemmo in scena una mostra vivente sulla “città infinita” che raccontava il protagonismo del “capitalismo molecolare” cresciuto come una supernova nella pedemontana lombarda e trasfigurato nell’antropologia dell’individualismo proprietario. Quel grande ceto medio operoso è stato poi pesantemente trasformato dalla metamorfosi che lo ha polarizzato tra un segmento alto, che è riuscito ad agganciarsi alle filiere globali, e un segmento di un “popolo dei vinti” con il suo saper fare in cerca di riscatto. Nel libro s’intravede una possibilità di rinascita mettendo a valore sociale ed economico il rapporto con i linguaggi della metropoli, a partire da Milano, città che ha “cultura di progetto”.
Tesi utile per ricomporre la faglia città-campagna all’epoca dell’urbano regionale purché la città-regione sia in grado di coniugare la discontinuità della modernità degli algoritmi e la continuità della tradizione del pensare, progettare e raccontare “manufatti”. Che sono espressione di una civiltà capace di interpretare la modernità secondo le proprie specificità. Per le città si tratta di praticare un’innovazione che “obbliga”, mettendosi in tensione con il patrimonio dei beni culturali viventi che stanno alla base del Salone del Mobile, della Settimana della Moda, quanto della produzione casearia d’alpe e ancor più delle mille varianti presenti in un Sud del Paese dalle tante tracce di civiltà materiale ancora vitali. Occorrono luoghi della ricomposizione della “frattura della conoscenza” che sono soprattutto le università a cui spetta il compito di contribuire a ricostruire un “senso del tutto”, riconoscendo e facendo alleanza con i saperi contestuali dei luoghi.
In questa prospettiva l’autore immagina figure professionali e militanti di “curatori di territorio”, che vadano oltre la figura dell’operatore di marketing territoriale invecchiata precocemente per burocratizzazione. I curatori di territorio sono una versione da economia leggera degli operatori di comunità di cui spesso si sente la mancanza, soprattutto con riferimento ai territori del margine. Sono figure che fanno “soglia” tra beni culturali viventi, nuovo patto con la natura e frontiera dell’innovazione tecnologica. «Tradizione è conservare il fuoco, non adorare le ceneri», così diceva il compositore Gustav Mahler citato nel libro. I beni culturali non sono solo pietre da conservare e da immettere nel circuito della turisticizzazione globale, ma anche i tanti “ muretti a secco” del saper fare. Reso vivente in quella filiera che va dalla terra come agricoltura al territorio come costruzione sociale che ha disegnato l’Italia borghigiana, l’Italia dei distretti e del Made in Italy che si ridisegna nell’epoca contemporanea del produrre per competere.

